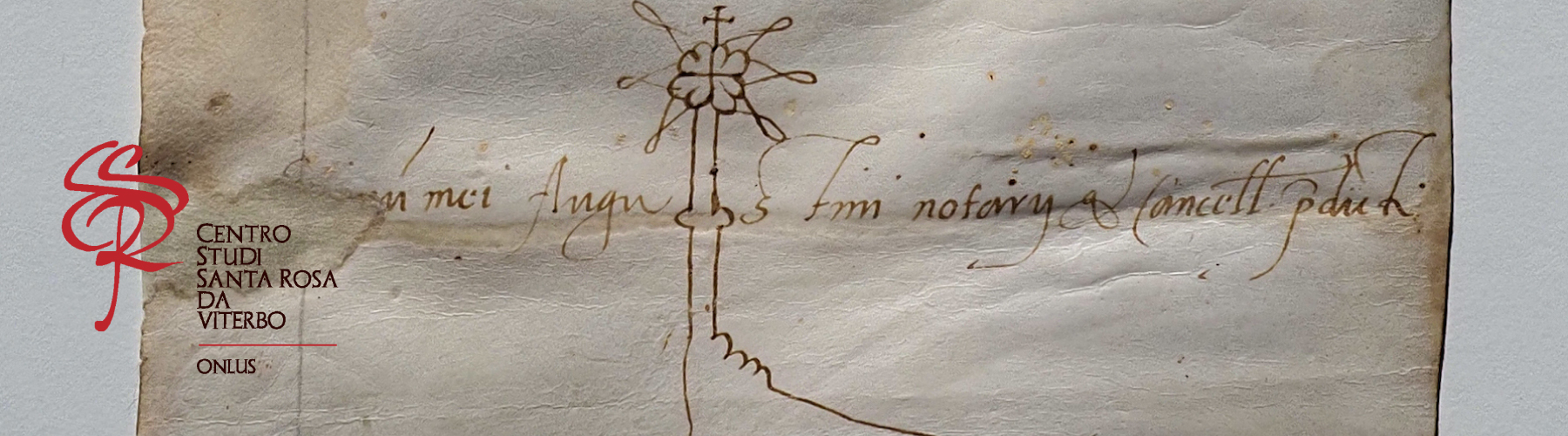Angelo Sapio
La devozione popolare per la Santa di Viterbo, come noto, si esprime massimamente in quell’evento folkloristico e votivo allo stesso tempo che ha luogo la sera del 3 settembre quando i Viterbesi si stringono alle vie attraversate dal trasporto della Macchina di S. Rosa. Quel legame quasi fisico che essi hanno con la loro Patrona e che racchiude tutto il senso di appartenenza alla comunità e ai suoi riferimenti identitari, quella sera viene trasmesso ad un sodalizio di uomini che si fanno carico di “scortare la Santa alla sua casa”, una metafora che si traduce appunto con il trasporto sulle spalle di un centinaio di Facchini di una vertiginosa torre illuminata sulla cui cima svetta la statua di s. Rosa.
Il percorso attraversa i principali assi viari del centro storico partendo dalla Porta Romana fino a giungere al sagrato del Santuario dove sono conservate le Sacre spoglie. Una desueta tradizione popolare ritraeva nel trasporto della Macchina una sorta di parabola della vita della Santa. La partenza avviene infatti presso la piccola chiesa di S. Sisto dove, stando alla suddetta tradizione mai confermata dalle fonti, Rosa avrebbe ricevuto il battesimo e si conclude laddove ella avrebbe voluto vivere i suoi ultimi giorni: quel Monastero che l’aveva prima rifiutata e poi accolta solo pochi anni dopo il beato transito. Il senso storico di questo tragitto discende in realtà dalle evoluzioni che hanno interessato nel tempo quell’antica processione civico-religiosa in onore della Santa che prendeva il nome di Luminaria e che a sua volta celebrava la ricorrenza della Traslazione del Corpo di Rosa avvenuto, sempre secondo tradizione, il 4 settembre del 1258 per volere di papa Alessandro IV.
Istituita nel 1512 con una delibera del Consiglio dei Quaranta del Comune di Viterbo, che intendeva così riconoscere giuridicamente la festa in onore della Patrona della città, dal secolo successivo vide trasferirsi la partenza dalla piazza del Comune alla Porta Innocenziana (Romana) per suggellare quel rapporto di obbedienza che legava Viterbo alla Chiesa. Gradualmente questa processione a cui partecipavano le maggiori cariche civili, oltre che i rappresentanti del mondo del lavoro, ottenne sempre maggior vigore grazie anche all’aggiunta di una struttura lignea mobile, illuminata da candele, contenente l’immagine di s. Rosa, che veniva condotta a spalla da un gruppo di portatori.
L’usanza non era del tutto nuova, sempre più numerosi in quel periodo erano gli altari votivi trasportati durante i cortei religiosi patronali in tutta l’area latina europea. Solo a Viterbo se ne contavano almeno tre (ben noti erano quelli del Santissimo Salvatore e della Madonna Liberatrice), ma il blasone e l’attrattività che caratterizzavano la luminaria di s. Rosa erano tali che assieme alla partecipazione cittadina aumentavano progressivamente anche le dimensioni del simulacro. Presto questo assunse la denominazione di Mole e poi ancora di Mole di Trionfo, Macchina Trionfale o più semplicemente Macchina, ad indicare un imponente complesso strutturale simile a quelli utilizzati per le scenografie delle opere teatrali. Cresceva in dimensioni l’immagine della Santa, cresceva il numero di ceri per illuminarla e così crescevano pure gli elementi decorativi che concorrevano alla creazione di una vera e propria opera d’arte in movimento.

I primi disegni di macchine pervenutici danno testimonianza di come inizialmente si realizzassero dei semplici baldacchini in stile barocco non troppo dissimili da quelli che tutt’oggi si possono osservare nelle città andaluse in occasione delle processioni per la Semana Santa. La rappresentazione di s. Rosa nasceva quindi sotto forma di una statua assisa su di un altare, per poi evolversi nel tempo in un’immagine dipinta racchiusa all’interno di un cupolino. Attorno ad essa man mano facevano la loro apparizione varie allegorie. Si andava dai semplici putti incastonati nei candelabri fino alle personificazioni di virtù teologali, speranza e carità le più riproposte, passando per la raffigurazione di svariati santi o di anonime cariatidi poste sotto a cornici marcapiano a mo’ di sostegno dei diversi livelli della macchina. Non mancavano neppure le rappresentazioni di miracoli o scene di vita della Santa, come la guarigione della bambina cieca o il risanamento della brocca di fronte alla fontana o ancora l’apparizione della Madonna durante la malattia e numerose altre.

Tale registro venne mantenuto per lunghissimo tempo nonostante il passaggio a nuovi stili. Col XIX sec. infatti il barocco lasciò spazio alle ordinate linee neoclassiche prima di approdare al ben più evocativo stile gotico, che resistette fino oltre la metà del secolo scorso, nonostante la breve parentesi tardo ottocentesca che rifletteva un certo fascino per il gusto moresco.
Tutte queste fasi, come detto, non tradirono mai il ricorso all’utilizzo di figure intermedie disposte lungo la macchina fino alla cima dove veniva posizionata ovviamente la Santa. Le macchine moderne, a partire dal Volo d’Angeli di Giuseppe Zucchi (1967-1978), si sono nettamente affrancate dai modelli tradizionali che prediligevano una struttura massiccia e spesso sovraccarica di complementi e decorazioni ed hanno piuttosto puntato ancor di più sulla verticalità e sulla scelta di un singolo soggetto peculiare riproposto varie volte su più livelli. Ai generici stilemi neo-gotici venivano ora a sostituirsi elementi connotativi dell’architettura viterbese come fontane, colonne, leoni o le merlature delle mura, ma soprattutto le vecchie figure antropomorfe della macchina perdevano definitivamente sembianze di santi, muse e virtù per assumere quelle di astratte allegorie angeliche. Queste erano ben presenti anche prima a onor del vero; angeli messaggeri con trombe o recanti fiori, ghirlande o coccarde figuravano spesso anche nei modelli dei Papini, di Bordoni o di Spadini, ma dalla seconda metà del ‘900 in poi presero nettamente il sopravvento.
Il primo approccio con la modernità arrivò col modello scelto per l’edizione del 1952 dell’architetto viterbese Rodolfo Salcini, assistente universitario alla facoltà di architettura di Roma La Sapienza, insieme allo scultore romano Francesco Coccia. L’arditezza delle innovazioni introdotte appariva immediata: non più un’infinità di piccole guglie sovrapposte ma un’unica grande guglia dalle linee razionali, una struttura metallica al posto di quella vecchia in legno e un’inedita illuminazione cangiante al neon, che andava a sostituire in gran parte le luci a fiamma viva, per simulare lungo il percorso una pioggia di rose. Polemiche prevedibili a parte, furono però le numerose statue degli angeli a generare il maggior scalpore. Il costruttore Romano Giusti si era avvalso della collaborazione dei maestri cartapestai viareggini, specializzati nelle costruzioni del celebre carnevale della Versilia, per la realizzazione delle allegorie. Forse per incomprensione o per una mal concordata licenza con gli autori vennero eseguite sculture dall’aspetto molto meno ieratico rispetto a quelle a cui i più erano abituati. Angeli quindi in apparenza molto più laici che sacri in un anno in cui Viterbo si apprestava a celebrare i festeggiamenti per i settecento anni dal Transito di s. Rosa.
Riportano così le cronache:
Già le prime indiscrezioni dei corrispondenti dei quotidiani romani avevano rivelato la disinvoltura con cui si erano superate le dotte disquisizioni sul sesso degli angeli per trasformare in floride ragazze quelle che fanno corona alla Santa, quando nell’agosto del 1952 scoppiò la bomba più grossa: il Prof. Coccia chiedeva il sequestro della costruzione perché riteneva che non fossero state rispettate le caratteristiche fissate nel progetto, specialmente per quello che riguardava la parte scultorea. Sebbene si fosse subito rilevato […] che il trasporto della Macchina poteva avvenire anche se essa fosse stata sequestrata ed affidata ad un custode giudiziario, tutta la cittadinanza trepidò e visse giorni di ansia. Finalmente il Prof. Coccia ritirò la sua istanza in attesa del parere di una commissione di artisti di fama internazionale che decidessero della sua asserzione ai fini dell’eventuale indennizzo per i danni morali da lui subiti per la menomazione della sua opera.[1]
Come sempre accade, ogni resistenza venne infine superata e la Macchina di Salcini sfilò per le vie di Viterbo per altre sei edizioni.
Temporaneo ritorno alla tradizione col modello goticheggiante di Angelo Paccosi (1959-1966) e finalmente la storia della macchina volta pagina con l’innovazione introdotta da G. Zucchi. Il suo “Volo d’Angeli” (questo era il nome scelto dall’autore), con un’altezza che superava addirittura i 30 metri, proponeva per la prima volta un “testo narrativo” semplice e diretto che ottenne subito un notevole consenso di pubblico. Si trattava per l’appunto di una colonna di quattro ordini di angeli (poi portati a cinque negli anni successivi) che elevavano in volo la Santa come su di un grande zampillo d’acqua. Gli angeli di Zucchi erano imponenti e comunicativi nonostante fossero disposti con le spalle rivolte al pubblico. In un’intervista a Quirino Galli l’autore rivelò:
All’inizio l’avevo messi di spalle [tra di loro] ma non andavano bene e gira gira li misi abbracciati: ricorderanno i paracadutisti quando si lanciano come quelli che stavano a Viterbo e spesso andavo a vederli quando si esercitavano. La macchina fu ispirata da quello che fece la Divisione Folgore, cose inaudite, contro i carri armati inglesi. […] Gli ultimi paracadutisti che partirono, compreso il generale comandante e lo Stato Maggiore, andarono a S. Rosa a chiedere la grazia e non chiesero né di vincere, né di ritornare, ma che a loro non mancasse l’onore”. […] Si recarono a visitare Santa Rosa a mezzanotte: le suore dovettero aprire appositamente la Chiesa per quell’incontro. [2]
 L’idea primigenia di questo stuolo angeli gli venne suggerita inizialmente dal figlio Luigi, all’epoca appassionato lettore delle avventure degli “uomini-falco” di Flash Gordon, eroi dei fumetti americani creati dalla fantasia di Alex Raymond, divenuti strisce di successo anche in Italia. Furono queste creature ibride e visionarie a colpire l’immaginario dell’autore della Macchina per la loro possibile associazione con i paracadutisti della Folgore ed un tipo di lancio che questi ultimi effettuavano, chiamato appunto “salto a volo d’angelo”. Interessante dunque la lettura finale che ne dà Antonio Riccio nel suo Saggio Antropologico:
L’idea primigenia di questo stuolo angeli gli venne suggerita inizialmente dal figlio Luigi, all’epoca appassionato lettore delle avventure degli “uomini-falco” di Flash Gordon, eroi dei fumetti americani creati dalla fantasia di Alex Raymond, divenuti strisce di successo anche in Italia. Furono queste creature ibride e visionarie a colpire l’immaginario dell’autore della Macchina per la loro possibile associazione con i paracadutisti della Folgore ed un tipo di lancio che questi ultimi effettuavano, chiamato appunto “salto a volo d’angelo”. Interessante dunque la lettura finale che ne dà Antonio Riccio nel suo Saggio Antropologico:
Gli angeli in volo erano quindi la «trascrizione occulta» della nuova macchina viterbese, trasformata in un ex-voto a testimonianza dell’onore salvato dei paracadutisti italiani caduti ad El-Alamein. [3]
 Anche il modello successivo, “Spirale di Fede” di M. Antonietta Palazzetti Valeri (1979-1985), puntò su un soggetto semplice ed intuitivo: una sottile spirale merlata che si avvitava verso l’alto fino ad innalzare al cielo la statua della Santa. Anche in questo caso erano presenti degli angeli ma, seppur in numero cospicuo, consistevano in bassorilievi di piccole dimensioni che, come nei vecchi modelli, concorrevano a comporre l’insieme dell’opera. Più vistosi invece erano i leoni alla base che catturavano immediatamente l’attenzione dell’osservatore.
Anche il modello successivo, “Spirale di Fede” di M. Antonietta Palazzetti Valeri (1979-1985), puntò su un soggetto semplice ed intuitivo: una sottile spirale merlata che si avvitava verso l’alto fino ad innalzare al cielo la statua della Santa. Anche in questo caso erano presenti degli angeli ma, seppur in numero cospicuo, consistevano in bassorilievi di piccole dimensioni che, come nei vecchi modelli, concorrevano a comporre l’insieme dell’opera. Più vistosi invece erano i leoni alla base che catturavano immediatamente l’attenzione dell’osservatore.
 Discorso similare anche per “Armonia Celeste” del duo Joppolo-Antonini (1986-1990) dove un maestoso leone faceva sfoggio di sé su un’imponente base frutto di una fortunata sintesi tra gli scorci più caratteristici della Viterbo medievale. Al di sopra di questa un vortice di angeli musicanti si sprigionava portando in gloria la Santa. In questo caso i bassorilievi degli angeli avrebbero dovuto ricoprire un ruolo molto più preminente essendo essi stessi a costituire quel vortice ascendente, ma in realtà l’opera definitiva non corrispose perfettamente al bozzetto originale degli autori, in quanto le allegorie risultarono troppo poco pronunciate ed anche l’illuminazione finì per risentirne.
Discorso similare anche per “Armonia Celeste” del duo Joppolo-Antonini (1986-1990) dove un maestoso leone faceva sfoggio di sé su un’imponente base frutto di una fortunata sintesi tra gli scorci più caratteristici della Viterbo medievale. Al di sopra di questa un vortice di angeli musicanti si sprigionava portando in gloria la Santa. In questo caso i bassorilievi degli angeli avrebbero dovuto ricoprire un ruolo molto più preminente essendo essi stessi a costituire quel vortice ascendente, ma in realtà l’opera definitiva non corrispose perfettamente al bozzetto originale degli autori, in quanto le allegorie risultarono troppo poco pronunciate ed anche l’illuminazione finì per risentirne.

Il leone simbolo di Viterbo sembrò spodestare per un certo periodo l’egemonia dell’angelo come figura chiave all’interno della Macchina prima di perderne nuovamente il primato. Nell’onirica “Sinfonia d’Archi” di Angelo Russo (1991-1997), sotto il complesso gioco di curve che arrivava fino alla cima trovavano spazio unicamente due leoni semi-antropomorfi ispirati a quelli in peperino che svettano su due stele in Piazza del Plebiscito.
“Tertio Millennio Adveniente – Una Rosa per il Duemila” (Cesarini-Andreoli-Cappabianca, 1998-2002) fu il modello che ebbe il compito di scortare la tradizione viterbese verso il futuro e per farlo propose una sintesi originale dei vari stili che avevano fatto la storia della Macchina lungo i secoli. Forse come omaggio all’iconico Volo, due gruppi di angeli abbracciati, quasi in quella stessa posizione, si aggrappavano con le mani attorno ad esili colonnine come a voler raggiungere la Santa nella gloria. Interessante la scelta stilistica di queste allegorie dai tratti poco definiti, quasi evanescenti, ma allo stesso tempo capaci di carpire l’attenzione degli astanti. Uno degli angeli infatti guardava alle sue spalle, in direzione del pubblico, con espressione turbata e rapita allo stesso tempo, come a voler comunicare la sua sofferenza.
 Il salto definitivo nella modernità arrivò con “Ali di Luce” di Raffaele Ascenzi (2003-2008). Per la prima volta la Macchina aveva delle parti mobili, ali per l’appunto, che potevano aprirsi e richiudersi lungo il percorso attraverso un meccanismo interno. Nonostante un aspetto decisamente avveniristico rispetto ai disegni precedenti, anche qui le allegorie svolgevano un ruolo di primaria importanza. Leoni ed angeli tornavano a compartecipare dell’insieme narrativo della Macchina come a voler rimarcare il legame con le radici identitarie popolari e spirituali della comunità: quattro mascheroni leonini fuoriuscivano da un globo poggiante su una base che recitava il motto araldico della città di Viterbo (“Non metuens verbum leo sum qui signo Viterbum”), mentre tre ordini di angeli rivolti verso l’esterno scandivano i moduli della Macchina fino alla Santa.
Il salto definitivo nella modernità arrivò con “Ali di Luce” di Raffaele Ascenzi (2003-2008). Per la prima volta la Macchina aveva delle parti mobili, ali per l’appunto, che potevano aprirsi e richiudersi lungo il percorso attraverso un meccanismo interno. Nonostante un aspetto decisamente avveniristico rispetto ai disegni precedenti, anche qui le allegorie svolgevano un ruolo di primaria importanza. Leoni ed angeli tornavano a compartecipare dell’insieme narrativo della Macchina come a voler rimarcare il legame con le radici identitarie popolari e spirituali della comunità: quattro mascheroni leonini fuoriuscivano da un globo poggiante su una base che recitava il motto araldico della città di Viterbo (“Non metuens verbum leo sum qui signo Viterbum”), mentre tre ordini di angeli rivolti verso l’esterno scandivano i moduli della Macchina fino alla Santa.
Gli angeli di Ali di Luce non erano angeli qualsiasi, essi di fatti si ispiravano ad una celeberrima opera funeraria dello scultore romantico Giulio Monteverde: l’Angelo della Resurrezione. Si tratta di una statua in piombo realizzata nel 1898 a decorazione della tomba della famiglia De Parri nel cimitero monumentale di Viterbo. La stessa, in realtà, non è altro che una delle numerose copie realizzate dal Monteverde del più celebre monumento funebre per la famiglia Oneto al cimitero di Staglieno di Genova (1882), sempre sua opera[4]. Il soggetto ebbe una fortuna tale da essere riproposto nel tempo da diversi altri scultori nel tentativo di replicarlo, esattamente come accadde anche per il coevo Angelo del Dolore del Cimitero Acattolico di Roma (opera di William Wetmore Story, 1894).

Innumerevoli versioni sono rintracciabili in Italia e all’estero. Solo per citare alcuni esempi: nella chiesa di S. Agostino di Prato, al cimitero monumentale di Pavia, o a quello di Benetutti in prov. di Sassari, o ancora al Woodlaw Cemetery del Bronx a New York (USA), al Cementerio de Cristóbal Colón a l’Havana (Cuba), al Cementerio Recoleta di Buenos Aires (Argentina) e numerosissimi altri. Definito come un “testimone dell’ambiguo mistero del nulla”, l’Angelo di Monteverde ancora oggi è percepito come un’opera fortemente iconica e accattivante.
In Ali di Luce l’ideatore scelse di utilizzare l’espressività di questo angelo modificandone leggermente la postura a seconda della posizione lungo la Macchina. Gli angeli del primo ordine erano quelli che più si avvicinavano all’opera originale, tendevano infatti a guardare verso il basso ossia al globo su cui poggiavano, come ad osservare il mondo, con le braccia incrociate. Gli angeli del secondo ordine tendevano invece a porre lo sguardo sugli osservatori per interagire con loro ed invitarli a proseguire la visione, abbozzando un sorriso; anche le mani si scostavano leggermente dal petto. Infine, gli angeli de terzo ordine sollevavano il viso verso la Santa, con le mani che cercavano di elevarsi in segno di dono.
 A raccogliere il pesante testimone di Ali di Luce fu “Fiore del Cielo” (2009-2014), la creatura di Arturo Vittori e Andreas Vogler che ebbe anche il vanto di essere esposta in un padiglione dell’Expo di Milano del 2015. La misura stilistica cambia radicalmente pur rimanendo l’uso di una certa simbologia di facile comprensione. Ancora una volta angeli e leoni tornavano a compartecipare nella globalità della Macchina; ancora una volta ricorreva il motivo del vortice, qui a significare una colossale torcia floreale ed ancora una volta vi era una tripla ripetizione, in questo caso nelle tre sfere che evocavano la vita della Santa (la sua presenza terrena, la forza della sua fede, l’ascensione al cielo). Tuttavia l’elemento innovativo per cui verrà ricordata questa Macchina fu la cascata di petali di rosa lanciati ogni anno in una particolare fermata del trasporto, una soluzione studiata dagli autori per ottenere una maggiore interazione con il pubblico presente.
A raccogliere il pesante testimone di Ali di Luce fu “Fiore del Cielo” (2009-2014), la creatura di Arturo Vittori e Andreas Vogler che ebbe anche il vanto di essere esposta in un padiglione dell’Expo di Milano del 2015. La misura stilistica cambia radicalmente pur rimanendo l’uso di una certa simbologia di facile comprensione. Ancora una volta angeli e leoni tornavano a compartecipare nella globalità della Macchina; ancora una volta ricorreva il motivo del vortice, qui a significare una colossale torcia floreale ed ancora una volta vi era una tripla ripetizione, in questo caso nelle tre sfere che evocavano la vita della Santa (la sua presenza terrena, la forza della sua fede, l’ascensione al cielo). Tuttavia l’elemento innovativo per cui verrà ricordata questa Macchina fu la cascata di petali di rosa lanciati ogni anno in una particolare fermata del trasporto, una soluzione studiata dagli autori per ottenere una maggiore interazione con il pubblico presente.
 L’ultimo modello in ordine cronologico è infine “Gloria”, altra creazione dell’Arch. Raffaele Ascenzi. Inaugurata nel 2015, dovrebbe aver concluso il suo mandato nell’edizione del 2022 dopo la pausa forzata di due anni, causa pandemia. Con Gloria sembra tornare preponderante la tradizione con numerosi elementi gotici che tanto ben si sposano con le attese dei Viterbesi. Non mancano le iconiche bifore che ricordano la loggia del Palazzo Papale, ma anche rosoni, cuspidi, guglie e colonnine tortili, tutte ben assemblate come nella migliore tradizione dei Papini. Ad aver ispirato maggiormente l’autore fu però un oggetto ben noto nella devozione popolare dei Viterbesi verso la loro Patrona: il Reliquiario che contiene il Cuore della Santa[5].
L’ultimo modello in ordine cronologico è infine “Gloria”, altra creazione dell’Arch. Raffaele Ascenzi. Inaugurata nel 2015, dovrebbe aver concluso il suo mandato nell’edizione del 2022 dopo la pausa forzata di due anni, causa pandemia. Con Gloria sembra tornare preponderante la tradizione con numerosi elementi gotici che tanto ben si sposano con le attese dei Viterbesi. Non mancano le iconiche bifore che ricordano la loggia del Palazzo Papale, ma anche rosoni, cuspidi, guglie e colonnine tortili, tutte ben assemblate come nella migliore tradizione dei Papini. Ad aver ispirato maggiormente l’autore fu però un oggetto ben noto nella devozione popolare dei Viterbesi verso la loro Patrona: il Reliquiario che contiene il Cuore della Santa[5].

La Macchina ripropone dunque per tre volte in successione il corpo centrale del reliquiario arricchendolo di numerose allegorie. Sotto i pinnacoli, al posto dei santi incastonati nel reliquiario trovano spazio delle candide figure angeliche che sembrano lasciare la loro sede per librarsi in aria. Ognuno di questi angeli porta in mano una pergamena, a simboleggiare l’intercessione dei messaggi che i fedeli rivolgono alla Santa durante l’anno e che vengono raccolti in una teca all’interno del Santuario prima di essere inseriti direttamente nella Macchina il giorno del trasporto.
Un ulteriore elemento di novità è la comparsa di altre figure antropomorfe nella Macchina, oltre ai classici angeli, come non accadeva da moltissimo tempo. Si tratta di figure maschili che sorreggono le vasche su cui poggiano i primi tre moduli della struttura, come dei moderni Atlanti. Essi vogliono celebrare il sacrificio dei Facchini che da secoli sostengono il peso della loro responsabilità, una sorta di facchini ancestrali. Afferma l’ideatore:
“Sono dei portatori che non vestono i caratteristici abiti del trasporto… Sono facchini senza tempo, con dei turbanti in testa che ricordano il tipico fazzoletto e indumenti che lasciano intravedere alcune parti del fisico…Sono facchini angelici, poiché sono a immediato contatto con gli angeli. Nel quarto modulo scompaiono insieme all’architettura e la Macchina diventa solo un fatto spirituale”.
Le Macchine che erediteranno da Gloria oneri e onori della tradizione viterbese cercheranno misure stilistiche diverse, in accordo col passare dei tempi e delle tecnologie a disposizione, ma con ogni probabilità continueranno ad aver bisogno dell’ausilio di tutti quei simboli, come le mai troppo abusate figure angeliche, che potranno garantirne quel vincolo profondo con le radici umane e spirituali della “festa”.

Ancora ottima la conclusione che scaturisce dal saggio antropologico di Antonio Riccio:
Macchina e Santa (tra loro con-fuse) sono il genius loci, un emblema eccellente che diviene simbolo riassuntivo cittadino, formano un complesso artistico-architettonico che integra fontane, leoni, palme e scene di vita della Santa in una struttura in movimento, un teatro dinamico che ricapitola e assicura la trasmissione dell’ethos comunitario. [6]
Lo scrittore Orio Vergani, inviato del Corriere della Sera, di passaggio nel 1935 in una Viterbo lontana e provinciale, ebbe l’occasione di assistere al passaggio della Macchina e ne rimase colpito al punto da definirla di getto un “campanile che cammina”. Tale denominazione ovviamente si prestava puntuale all’aspetto che aveva all’epoca la macchina di Virgilio Papini, ma nonostante il passare degli anni, ancora oggi è così che la Macchina di S. Rosa viene esportata nel mondo.
[1] Sandro Vismara, “Cara Viterbo”. Aspetti, avvenimenti e personaggi nella Tuscia dal 1945 al 1985, Viterbo 2014.
[2] Quirino Galli, “I Facchini e il culto di Santa Rosa”, in “Santa Rosa: tradizione e culto”, a cura di Silvio Cappelli, VIterbo 1999.
[3] Antonio Riccio, “Santa Rosa e i Viterbesi”. Saggio antropologico, Viterbo 2018.
[4] Dall’angelo traspare una forte carica di emotività sensuale che rompe con gli schemi scultorei fino ad allora in voga: sebbene l’angelo regga con la mano destra la tromba del giudizio universale, la sua postura e il suo sguardo imperscrutabile hanno tutt’altro che un aspetto consolatorio, come ci si aspetterebbe da una figura angelica, facendolo apparire per contro lontano e distaccato rispetto all’evento di cui è muto testimone.
[5] Si tratta di un pezzo pregiatissimo in argento cesellato placcato in oro che venne donato al Monastero di S. Rosa nel 1929 dal papa Pio XI, il quale lo ebbe a sua volta in dono da un pellegrinaggio proveniente dal Santuario polacco della Madonna di Częstochowa. Nel 1984 Papa Giovanni Paolo II, in visita al Monastero, ne riconobbe la fattura.
[6] Antonio Riccio, “Santa Rosa e i Viterbesi”. Saggio Antropologico, Viterbo, 2018.