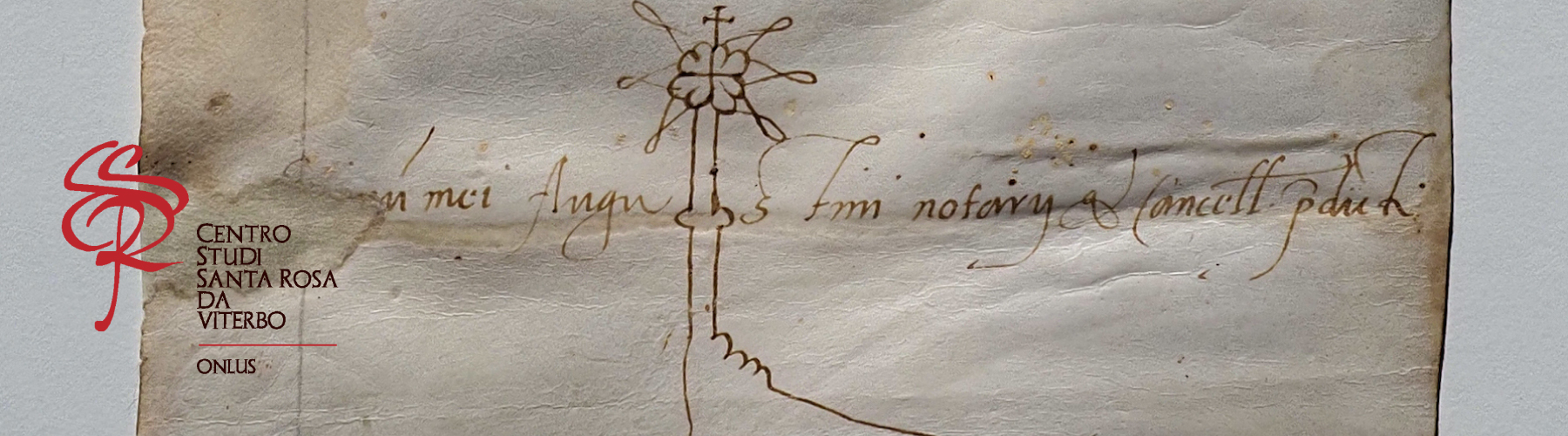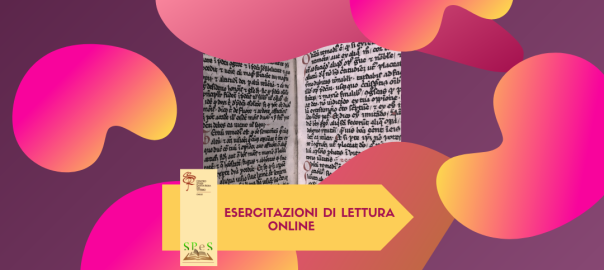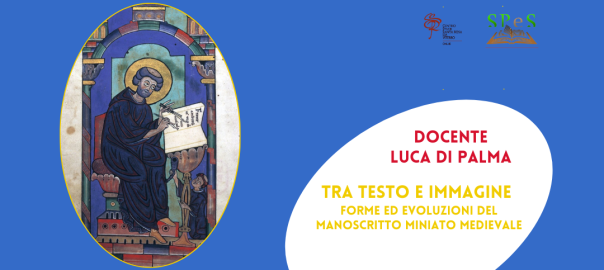Este año con motivo de la fiesta de Santa Rosa una delegación de la ciudad de Querétaro (México) estuvo en Viterbo para participar en las celebraciones rosianas y conocer el monasterio y las actividades del Centro de Estudios. El día del transporte de la Máquina también se les unió S.E. Sr. Alberto Medardo Barranco Chavarría, Embajador de México ante la Santa Sede. Hemos recolectado testimonios de Nicte-Há Rico Sosa, directora de la Coordinación de Patrimonio Inmaterial y celebraciones comunitarias de Querétaro, José Niembro, director del Museo de Arte Sacro de Querétaro y su colega Joel Pérez. Escuchamos por sus voces en vivo lo que significó esta experiencia.
Quest’anno per la festa di santa Rosa una delegazione della città di Queretaro (Messico) è stata a Viterbo per partecipare alle celebrazioni rosiane e per conoscere il monastero e le attività del Centro Studi. Il giorno del trasporto della Macchina si è unito a loro anche S.E. il Sig. Alberto Medardo Barranco Chavarría, Ambasciatore del Messico presso la Santa Sede. Abbiamo raccolto le testimoniane di Nicte-Há Rico Sosa, direttrice del Coordinamento del Patrimonio Immateriale e feste comunitarie di Queretaro, José Niembro, direttore del Museo di Arte Sacra di Queretaro e il suo collega Joel Pérez. Sentiamo dalle loro vive voci cosa ha significato questa esperienza.
Fiesta y tradición: devoción a santa Rosa de Viterbo
Una de las características de la festividad de santa Rosa que nos une con Viterbo, Italia, es la gran devoción con que los habitantes de estas dos poblaciones viven las actividades religiosas que se realizan en honor de la Santa; además de que en Querétaro se encuentra el único templo dedicado a santa Rosa en México, razón por la cual vale la pena destacar la importancia de mantener vivas la tradiciones de ambas regiones, a partir del fortalecimiento de los lazos de cooperación, solidaridad y apoyo que se entretejieron este año.
Al mismo tiempo que en Querétaro se celebra la fiesta en honor de Santa Rosa, en la ciudad de Viterbo, Italia, se realiza la gran fiesta en honor de la misma Santa, que inició desde hace casi un mes con diversos eventos, uno de los cuales es el recorrido de la Macchina di Santa Rosa por el centro de Viterbo; dicha Macchina – con un peso aproximado de cinco toneladas – es cargada por cien hombres que caminan una distancia mayor a un kilómetro entre la algarabía de los asistentes, los llamados facchini, los encargados de cargar la Macchina ataviados de blanco y rojo con un pañuelo en la cabeza son bendecidos por el obispo con una plegaria especial antes de comenzar.
La leyenda cuenta que la procesión se remonta al año 1258, cuando el papa Alejandro IV ordenó el traslado del cuerpo (incorrupto) de santa Rosa a la iglesia de Santa Maria (después de S. Rosa) y para presenciar este importante evento se congregaron miles de personas. Dicho traslado se recuerda con una festividad muy esperada tanto por sus habitantes como por los visitantes provenientes de varios lugares. Cabe señalar que la tradición de la Macchina fue declarada por la UNESCO, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
En la ciudad de Querétaro, en la víspera de la festividad, dieciocho jóvenes del barrio de Santa Rosa se visten con túnicas, diademas de rosas y un crucifijo que asemejan las utilizadas por la santa en el siglo XIII y participan en la procesión que se realiza por las calles del barrio y en la celebración eucarística del día principal de la fiesta.
A través de la colaboración que este año se realizó entre Querétaro – México y Viterbo – Italia, se fortalecen los vínculos culturales entre ambas ciudades y se construye el andamiaje para que la fiesta y la tradición en honor a esta santa que las une, perviva y se fortaleza en el tiempo.
Nicte-Há Rico Sosa
Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro
Rosa de Viterbo, una sensible joven modelo de integración y fraternidad a casi 8 siglos en torno a la máquina!
Soy José Niembro Calzada, nací Santiago en Querétaro [México] ciudad inscrita en la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, y en la cual tenemos el majestuoso templo barroco conocido como Real Beaterio de Sta. Rosa de Viterbo. Este pulcro lugar fue erigido para las religiosa Rosas y atendido por ellas por casi dos siglos, logrando la participación de muchas personas en su patrocinio y profesión de la fe. Por otro lado, desde hace 9 años tengo el gusto de dirigir el Museo de Arte Sacro de la Diócesis de Querétaro, además de ser un convencido de la importancia del turismo religioso; en este sentido, y con apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno estatal, mi compañero Joel Pérez y yo acudimos a la fiesta de Santa Rosa de Viterbo que recién se llevó a cabo en Italia y que por mucho rebasó mis expectativas.
De Rosa de Viterbo sabemos poco por lo que nos entusiasma colaborar con el Centro Estudi Santa Rosa da Viterbo, un lugar de encuentro de académicos de talla internacional empañados en estudios medievales sean históricos, filológicos, artísticos, paleográficos … vemos que hay mucho por descubrir y con alegría esperamos la oportunidad de conocer más sobre Santa Rosa.
Vivimos la experiencia de la sorprendente ofrenda que año con año hacen a Sta. Rosa mediante la Máquina, por ello, si algo tenemos que destacar es la enorme participación de la gente; los viterbeses con mucha emoción, convicción y respeto proponen, construyen y colaboran con ésta, su gran fiesta; una composición de enorme fe y buen gusto, con significados artísticos, teólogos e iconográficos.
Es emocionante participación de los faquinos, sin duda los protagonistas de la celebración, quienes debidamente coordinados no temen al peso, peligro y desafío de portar hasta los pies de la Santa en su Santuario la enorme ofrenda que su pueblo le preparó. No tengo palabras para agradecer y reconocer a las autoridades, organizadores, padres de familia, faquinos (niños y adultos) y todos los viterbeses que hicieron inolvidables unos segundos de las vidas de miles de espectadores que gritamos, aplaudimos y lloramos de emoción al tener esta enorme luz llena de vibras extraordinarias que Dios nos da mediante esa maravillosa ofrenda.
Gracias al Mstro Filippo Sedda y al Centro Estudio Santa Rosa da Viterbo por la invitación al lugar que nos permitió disfrutar de este gran espectáculo, gracias por dejarnos conocer más a la Santa y gracias a las religiosas que motivan e impulsan esta festividad; gracias también al obispo Horacio Piazza por su palabra y gracias a la municipalidad por estar presentes en cada momento que pudimos vivir. Viterbo tiene en sus manos una grave responsabilidad, mantener la tradición para las generaciones venideras y que se preserve con respeto.
Muchas gracias y felicidades a todos quienes hacen posible esta gran fiesta. Hago votos para que en Querétaro en proporciones guardadas podamos acercarnos a una posible celebración como la que los italianos son capaces de hacer. Está fiesta logra arraigo e identidad por su pueblo y esto da como resultado armonía y buena convivencia.
Dios bendiga a Viterbo!
José Niembro
Una tradición viva en el corazón de un Mexicano.
El pasado 3 de septiembre de 2024, tuve la oportunidad de presenciar por primera vez el transporte de la *Macchina di Santa Rosa* en Viterbo, una experiencia que me sobrecogió tanto emocional como espiritualmente. Ver a los *Facchini* – los hombres encargados de soportar la estructura de más de 30 metros de altura y 5 toneladas de peso – me generó una profunda admiración por su devoción y fortaleza física. Cada paso que daban al ritmo del grito “Santa Rosa” era un testimonio vivo de una tradición que, desde 1664, une a la ciudad en un espectáculo de fe y comunidad.
La *Macchina*, una torre iluminada en honor a Santa Rosa, patrona de Viterbo, con más de 800 luces recorre las calles de la ciudad en una procesión nocturna que transcurre entre la multitud expectante. El origen de esta tradición se remonta al siglo XIII, cuando los restos de la joven santa fueron trasladados desde su lugar de descanso a la iglesia y monasterio de S. Maria (después S. Rosa). En los siglos posteriores, la traslación evolucionó hasta convertirse en la imponente procesión que se lleva a cabo hoy, con una estructura renovada cada cuatro años para reflejar la gloria y milagros de la santa.
La palpable unión entre los ciudadanos, quienes celebran este acto no solo como una expresión de fe, sino como un símbolo de identidad. Ver cómo la “Macchina” avanzaba por las estrechas calles de Viterbo, levantada por la fuerza humana acompañada de una emoción colectiva, es el recordatorio del poder de las tradiciones para conectar generaciones y mantener viva la memoria de un pasado compartido.
Como Queretano me siento privilegiado y conmovido de poder expresar estas palabras, recordar la vida de la Santa me hacen un devoto más que nos compromete a los Queretanos a conocer más de su vida y obra, recordando que en esta “Muy noble y leal ciudad” de Santiago de Querétaro tenemos el imponente Templo de Santa Rosa de Viterbo que es icono de la arquitectura barroca del Centro Histórico declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1996.
¡Qué viva Santa Rosa!
Ing. Joel Pérez Dorantes













Fiesta y tradición: devoción a santa Rosa de Viterbo, a cura del Coordinación de Patrimonio Inmaterial de Queretaro
TRADUZIONE IN ITALIANO
Festa e tradizione: devozione a santa Rosa da Viterbo
Una delle caratteristiche della festa di Santa Rosa che ci unisce con Viterbo, in Italia, è la grande devozione con cui gli abitanti di queste due città vivono le attività religiose che si svolgono in onore della Santa; inoltre, a Querétaro si trova l’unico Santuario dedicato a Santa Rosa in Messico, motivo per cui vale la pena sottolineare l’importanza di mantenere vive le tradizioni di entrambe regioni, rafforzando i legami di cooperazione, solidarietà e sostegno che si sono intrecciati durante questo periodo. anno.
Nello stesso momento in cui si celebra la festa in onore di Santa Rosa a Querétaro, nella città di Viterbo, in Italia, si tiene la grande festa in onore della stessa Santa, iniziata quasi un mese fa con vari eventi, uno dei qual’ è il percorso della Macchina di Santa Rosa attraverso il centro di Viterbo; detta Macchina – del peso di circa cinque tonnellate – viene trasportata da un centinaio di uomini che percorrono a piedi un percorso di oltre un chilometro in mezzo al rumore degli assistenti, i cosiddetti facchini , coloro chi caricano della Macchina vestiti di bianco e rossi con un fazzoletto sulla testa, vengono benedetti dal vescovo con una preghiera speciale prima di iniziare.
La leggenda narra che la processione risale all’anno 1258, quando papa Alessandro IV ordinò la traslazione del corpo (incorrotto) di Santa Rosa nella chiesa di Santa Maria (poi di S. Rosa) e migliaia di persone si sono riunite per assistere a questo importante evento. Questo trasferimento viene ricordato con una festa tanto attesa sia dagli abitanti che dai visitatori provenienti da varie località. Da sottolineare che la tradizione della Macchina è stata dichiarata dall’UNESCO, Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.
Nella città di Querétaro, alla vigilia della festa, diciotto giovani del quartiere di Santa Rosa si vestono con tuniche, diademi di rose e un crocifisso che ricorda quell’ usato dalla santa nel XII secolo, queste giovane partecipano alla processione che si svolge per le vie del quartiere e nella celebrazione eucaristica del giorno della festa.
Attraverso la collaborazione realizzata quest’anno tra Querétaro – Messico e Viterbo – Italia, si rafforzano i legami culturali tra le due città e si costruiscono le basi affinché la festa e la tradizione in onore di questa Santa che ci unisce, sopravviva e sia rafforzato nel tempo.
Nicte-Há Rico Sosa
Segretaria della Cultura dello Stato del Querétaro
Rosa de Viterbo, una giovane sensibile modello di integrazione e fraternità da quasi 8 secoli attorno alla macchina!
Sono José Niembro Calzada, sono nato a Santiago di Querétaro [Messico], città iscritta dall’UNESCO come patrimonio culturale dell’umanità, e nella quale abbiamo il maestoso Santuario barocco conosciuto come Real Beaterio de Santa Rosa da Viterbo. Questo bel luogo fu eretto per le monache Rosas e da loro curato per quasi due secoli, ottenendo la partecipazione di numerose persone al loro mecenatismo e professione di fede. D’altronde da 9 anni ho il piacere di dirigere il Museo d’Arte Sacra della Diocesi del Querétaro, oltre ad essere convinto dell’importanza del turismo religioso; in questo senso, e con il sostegno della Segretaria della Cultura del governo della regione, io e il mio collega Joel Pérez abbiamo partecipato alla festa di Santa Rosa da Viterbo che si è appena celebrata in Italia e che ha superato enormemente le mie aspettative.
Sappiamo poco di Rosa de Viterbo, motivo per cui siamo entusiasti di collaborare con il Centro Studi Santa Rosa da Viterbo, un luogo di incontro per accademici di statura internazionale immersi negli studi medievali, siano essi storici, filologici, artistici, paleografici… noi vediamo che c’è molto da scoprire e aspettiamo con gioia l’occasione di conoscere meglio Santa Rosa.
Abbiamo vissuto l’esperienza della sorprendente offerta che anno dopo anno si fa a Santa Rosa attraverso la Macchina, quindi, se c’è qualcosa da evidenziare è l’enorme partecipazione della gente: i viterbesi con grande emozione, convinzione e rispetto propongono, costruiscono e collaborano a questa loro grande festa; una composizione di enorme fede e buon gusto, con significati artistici, teologici e iconografici.
È una partecipazione emozionante quella dei facchini, senza dubbio i protagonisti della celebrazione, che, opportunamente coordinati non temono il peso, il pericolo e la sfida di portare ai piedi della Santa nel suo Santuario la grande offerta che il popolo ha preparato. Non ho parole per ringraziare e applaudire le autorità, gli organizzatori, i genitori, i facchini (bambini e adulti) e tutti i viterbesi che hanno reso indimenticabili alcuni secondi della vita di migliaia di spettatori che hanno gridato, applaudito e pianto di commozione per avere questo enorme luce piena di vibrazioni straordinarie che Dio ci dona attraverso questa meravigliosa offerta.
Grazie al dott. Filippo Sedda del Centro Studi Santa Rosa da Viterbo per l’invito nel luogo che ci ha permesso di godere di questo grande spettacolo, grazie per averci fatto conoscere meglio la Santa e grazie alle suore che motivano e promuovono questa festa; grazie anche al vescovo Francesco Orazio Piazza per le sue parole e grazie al Comune per essere stato presente in ogni momento che abbiamo potuto vivere. Viterbo ha tra le mani una seria responsabilità: mantenere la tradizione per le generazioni future e preservarla con rispetto.
Grazie mille e complimenti a tutti coloro che rendono possibile questa grande festa. Spero che Querétaro possa avvicinarsi a una possibile celebrazione come quella che sanno fare gli italiani. Questa festa raggiunge radici e identità per la sua gente e questo si traduce in armonia e buona convivenza.
Dio benedica Viterbo!
Dr. José Niembro
Una tradizione viva nel cuore di un messicano
Il 3 settembre 2024 ho avuto l’opportunità di assistere per la prima volta al trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo, un’esperienza che mi ha travolto sia emotivamente che spiritualmente. Vedere i Facchini – gli uomini incaricati di sostenere la struttura alta più di 30 metri e pesante 5 tonnellate – mi ha suscitato profonda ammirazione per la loro devozione e forza fisica. Ogni passo compiuto al ritmo del grido “Santa Rosa” era testimonianza viva di una tradizione che, dal 1664, unisce la città in uno spettacolo di fede e di comunità.
La Macchina, una torre illuminata in onore di Santa Rosa, patrona di Viterbo, con più di 800 luci percorre le vie della città in una processione notturna che passa attraverso una folla in attesa. L’origine di questa tradizione risale al XIII secolo, quando le spoglie della giovane santa furono traslate dal suo luogo di riposo alla chiesa e monastero di S. Maria (poi S. Rosa). Nei secoli successivi la traslazione divenne l’imponente processione che si svolge oggi, con una struttura rinnovata ogni quattro anni per riflettere la gloria e i miracoli della santa.
C’è un’unione palpabile tra i cittadini, che celebrano questo atto non solo come espressione di fede, ma come simbolo di identità. Vedere come la Macchina avanzava tra le strette vie di Viterbo, sollevata dalla forza umana accompagnata dall’emozione collettiva, ricorda il potere delle tradizioni di connettere generazioni e mantenere viva la memoria di un passato condiviso.
Come queretano mi sento privilegiato e commosso nel poter esprimere queste parole, ricordare la vita della Santa mi rende più devoto e impegna la gente di Querétaro a conoscere meglio la vita e l’opera di Santa Rosa, ricordando che questa “Molto nobile e leale città” di Santiago de Querétaro possiede l’imponente Santuario di Santa Rosa da Viterbo, icona dell’architettura barocca del Centro Storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità nel 1996.
Viva Santa Rosa!
Ing. Joel Pérez Dorantes