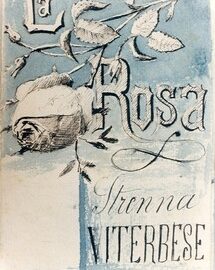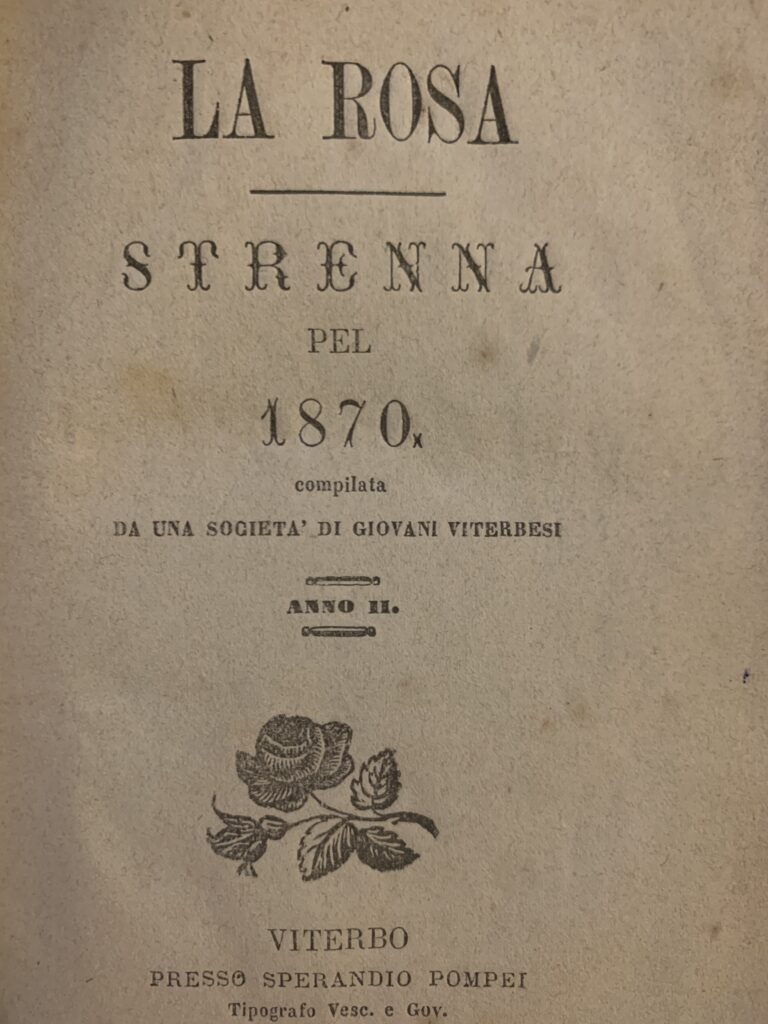Seconda Parte: Sulle tracce di santa Rosa in Messico a cura di Stefano Aviani Barbacci
Vai alla prima parte.
Nell’immagine di copertina:
Santa Rosa da Viterbo che fu a Colón con le Rositas portata in processione a Querétaro
La storia delle Rositas inizia il 23 Aprile del 1670 con la decisione della vedova Antonia de la Encarnación de Herrera e delle figlie Francisca de los Ángeles, Clara de la Asunción e Gertrudis de Jesús y María di dedicarsi a una vita di preghiera e servizio, accogliendo bambine orfane nella propria abitazione. Nel 1702 il francescano José Díaz formalizza una regola per la vita comune e fa di Francisca de los Ángeles (1674-1744), mistica e veggente fin dall’età di 5 anni, la prima responsabile di un Beaterio destinato a diventare in breve tempo il Colegio e poi il Real Colegio di Querétaro, tra le più importanti istituzioni religiose nella storia del Messico. In grado di leggere e scrivere, Francisca ci ha lasciato una corrispondenza di centinaia di lettere (in parte ancora inedite) di straordinario interesse per chi voglia indagare la religiosità dell’epoca del Virreinato e la fede appassionata di una giovane creola che Ellen Gunnarsdottir, nel suo “Mexican Karismata” (2004), definisce un sorprendente “intreccio di ortodossia tridentina, spiritualità medievale e cultura popolare messicana”. Questo mondo sarebbe in larga misura scomparso con le “Leggi di Riforma” promulgate, tra il 1855 e il 1860, da governi determinati a recidere ogni elemento di continuità con l’epoca novohispana e a cancellare la persistente influenza della Chiesa cattolica nella vita del popolo messicano. L’applicazione intransigente di tali leggi alimenterà un conflitto latente tra élite e popolo, destinato ad esplodere nel 1926 con l’insurrezione cosiddetta dei cristeros.
Nel 1863 le Rositas sono espulse dal Colegio de Santa Rosa de Viterbo per effetto della Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (del 12 Giugno 1859). Ciò nonostante, si trattengono a Querétaro ancora per quattro anni, dapprima sistemate nel Convento de Santa Clara (ora confiscato, ma che era stato tra i più importanti del periodo novohispano) e poi riabitando alcuni locali caduti in rovina del Colegio de Santa Rosa de Viterbo. In questo periodo accolgono ancora 5 novizie. Nel 1867 i repubblicani di Benito Juarez espugnano Querétaro dopo un duro assedio e fucilano l’arciduca Massimiliano d’Asburgo (Imperatore del Messico dal 1864 al 1867). A tutti i religiosi è imposto di abbandonare la vita consacrata e disperdersi. Preparatesi da tempo a questa eventualità, le più giovani tra le Rositas si incamminano lungo il sentiero che attraversa la Sierra Gorda, determinate a ricominciare altrove la vita di comunità. Le guida Madre Teodosia (María Teodosia de la Conceptión). Sarà una vera epopea, attraverso una regione montuosa e selvaggia, dovendo evitare i luoghi più frequentati e le pattuglie dei militari, camminando scalze lungo le mulattiere sassose, dormendo all’addiaccio e talora sotto la pioggia, soffrendo la fame e la sete… Sfinite, giungono infine a Tolimanejo (oggi Colón) il 15 Settembre 1868 (la data è riportata in un manoscritto di Madre Teodosia del 1904) dove sono soccorse dalla popolazione. Tre di loro si ammalano e perdono la vita. Alcune altre proseguono per stabilirsi a Cadreyta, presso la locale Capilla de laInmaculada Conceptión.

Cacciata di Rosa da Viterbo, dalla “Vida de Santa Rosa da Viterbo” di José de Nava
In un periodo successivo è inviata loro da Querétaro una raffigurazione scultorea di Santa Rosa da Viterbo (come venne riferito da Madre Paz al giornalista José Manuel Escobedo, il 4 Maggio 1987), preziosa opera della fine del XVII secolo o dell’inizio del XVIII, vestita di un abito di broccato e con al collo un prezioso medaglione con l’immagine della Vergine Addolorata. Giungono anche alle Rositas una statua di San Francesco d’Assisi e un Bambin Gesù, della seconda metà del XIX secolo, lavoro di un ebanista di Città del Messico. Si svolge di nuovo il “capitolo” e la vita religiosa prudentemente riprende nell’epoca in cui Porfirio Diaz governa il Paese (1872-1911). Il suo governo non abroga le leggi anticlericali preesistenti, ma (essendo la moglie cattolica) si astiene dal richiederne una rigida applicazione. Tolimanejo (già missione francescana col nome di San Francisco di Tolimanejo) viene unita alla vicina Soriano (già missione domenicana col nome di San Domingo de Soriano) e alle haciendas di Zamorano e Ajuchitlán dando luogo a una medesima parrocchia dal 1825 e ad un medesimo municipio, col nome di Colón, dal 1885. Il convento delle Rositas è prossimo alla parrocchia, con un terreno riservato per le sepolture nel vicino cimitero di San Francesco. La regola torna quella dell’epoca di Querétaro che prevede la clausura (nei limiti delle concrete possibilità) e un tunnel permette loro di attraversare la strada per recarsi, non viste, nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Tra le novizie che entrano nel periodo colonense: Maria de la Paz (Madre Paz), al secolo Pomposa Garduño (Orduño in alcune fonti), nata il 19 Settembre 1875 ad Amealco, professa nel 1893 (a 18 anni).
Si era già deciso di accogliere solo quelle giovani che consentissero di tener fermo il numero di 12-13. Dopo il 1913 la vita religiosa in Messico precipita ancora in una condizione di precarietà estrema. Una mostra allestita nel Marzo del 2019 a Querétaro ricorda le difficili circostanze di quel periodo e riferisce al 1918 l’ultimo ingresso di una novizia nella comunità (senza più alcuna possibilità di indossare l’abito). Una casseruola di rame e le paginette sgualcite di un ricettario documentano una produzione di dolci (tra i quali i canditi preparati con frutti selvatici raccolti sui monti di Zamorano) la cui vendita consentiva alle Rositas di sopravvivere. Di grande interesse storico il manoscritto titolato: “Copia de las Constituciones del Colegio de Santa Rosa de Viterbo”, iniziato, come si legge in calce, il 26 Maggio del 1867, poco prima dell’abbandono di Querétaro. Agli inizi degli anni ’20 la vicenda di quella comunità è ormai prossima a concludersi dato che, come rievoca Rosa María Cabrera Ruiz nel suo “El ciclo de vida de un espinoso rosal” (2017), la Guerra Cristeranon avrebbe risparmiato quel municipio e l’inasprirsi della persecuzione avrebbe causato infine l’estinguersi di quella secolare e significativa esperienza di vita religiosa.
La Guerra Cristera (1926-1929) inizia quando la politica anticattolica raggiunge il suo acme sotto la presidenza del massone Plutarco Elías Calles (1877-1945), uno dei generali che avevano contribuito alla sconfitta di Francisco “Pancho” Villa nel 1915. Dal 1924 Calles domina il Paese con pugno di ferro. Il suo partito si definisce dapprima “laburista” e poi “rivoluzionario istituzionale”. Intransigente fautore di una politica cosiddetta “modernizzatrice”, Calles guarda con simpatia alla neonata Unione Sovietica, ma al tempo stesso si procura l’appoggio degli Stati Uniti in cambio di concessioni sullo sfruttamento del petrolio di cui il Messico si scopre ricco. Di nuovo a rischio d’esser catturate, le ultime Rositas lasciano il convento (oggi in via Francisco I, Madero n. 122) il 19 Dicembre del 1926. Alcune tornano ai propri villaggi, altre trovano rifugio presso le famiglie del luogo. Due sacrestani sono già stati fucilati e chi le accoglie sa bene che i federales passano per le armi non solo i religiosi, ma chiunque li aiuti… Alessandro Finzi, nel suo Santa Rosa in Messico” (2006), riporta un episodio emblematico al riguardo (già riferito da Madre Paz alla signora María de la Luz Gutiérrez Zarazúa che le era stata vicina negli ultimi suoi anni di vita): “una volta le fermò un gruppo di soldati, ma quando questi videro Madre Guadalupe (María de Guadalupe Becerra, di Pinal de Zamorano, l’ultima priora della comunità) con il Bambin Gesù avvolto in uno scialle, il Capitano disse: ‘Lasciatele andare, hanno un bambino in braccio’ (ogni volta che uscivano portavano con loro il Bambin Gesù) e per questo si salvarono”.
Il 4 Febbraio 1928, Colón insorge. Un centinaio di miliziani, al seguito del comandante cristero Manuel Frías, si radunano presso il Rancho El Derramadero per filtrare poi tra le case imbracciando fucili máuser (come da una testimonianza). L’impresa riesce e i ribelli si impadroniscono del municipio. Al fianco di Frías vi sono eminenti colonensi coinvolti nella causa degli insorti. Percorrono insieme la via principale (che oggi è il Corso Michoacán) applauditi dalla popolazione e le campane di Colón suonano a festa per salutare la liberazione. Raggiungono infine la popolare Basilica de Soriano, nella parte della città conosciuta ancor oggi come Soriano de Colón. Il santuario accoglie un’immagine sacra assai venerata e cara alle stesse Rositas, quella di Nuestra Señora de los Dolores. I ribelli vi entrano per ringraziare e rendere omaggio a quella che popolarmente è conosciuta come “la Dolorosa”. I cristeros si considerano un esercito regolare, l’Esército Nacional Libertador, costituitosi in difesa della libertà religiosa e per la salvezza del Paese dalla tirannia. La loro bandiera si ispira a quella portata in battaglia da Emiliano Zapata negli anni ’10, con la Vergine di Guadalupe e i colori del Messico. Colón tornerà sotto il controllo dei governativi solo il 19 Luglio del 1929, un mese dopo la firma degli accordi (i cosiddetti “arreglos”) che mettono fine alla Guerra Cristera. Un gruppo di guardias blancas, sostenute dalla popolazione locale, continuerà ad operarvi contro i governativi fino al 1940.

Il “Niño Dios de las Rosas” che appartenne alle Rositas, oggi a Soriano de Colón
Dopo la guerra, espropriato il convento, Madre Paz e Madre Guadalupe devono recarsi a Città del Messico per lavorare e mettere insieme il denaro sufficiente a comprare una nuova casa. Troveranno una modesta sistemazione (tre stanze, una cucina e un orto) a Soriano di Colón e sarà dunque questo il luogo del loro ultimo esilio. Questa circostanza appare sorprendente, essendo stata Santa Rosa da Viterbo, nel 1251, esiliata lei stessa in un luogo di nome Soriano, oltre i monti Cimini del viterbese. Li si stabiliscono la Madre Guadalupe e la Madre Paz, con Madre Luz [Si tratta di Maria de la Luz de Olvera, di Ajuchitlán, morta a Colón in fama di santità e di cui Madre Paz testimoniò di aver ritrovato il corpo incorrotto e profumato al momento della sepoltura di Madre Guadalupe (Madre Luz era stata sepolta nel medesimo luogo 10 anni prima)], Madre Cholita e la signorina Celestina, che vive con loro pur non essendo professa. Qualcun’altra è tornata ai villaggi d’origine. Madre Paz è quell’ultima Rosa di cui narra il sociologo e giornalista queretano José Felix Zavala nel suo “La última Rosa: Pomposa Garduño” (2011). Rimasta sola, assistita da quella medesima famiglia Gutiérrez che l’aveva nascosta negli anni della Guerra Cristera, Madre Paz muore nel 1987 alla veneranda età di 112 anni: 317 anni dopo la nascita del Beaterio de Santa Rosa de Viterbo. Per sua volontà, la statua di Santa Rosa da Viterbo era già tornata a Querétaro nel 1985, quella del Bambin Gesù (con la quale Madre Paz amava confidarsi e parlare) si trova invece a Soriano de Colón, nella medesima Basilica de la Virgen Dolorosa dove restava esposta alla devozione dei colonensi nei giorni compresi tra il 24 Dicembre e il 6 Gennaio, inserita tra le altre figure del Presepe. Il Bambin Gesù grazie al quale Madre Guadalupe aveva avuto salva la vita lo si conosce oggi come “el Niño Dios de las Rosas” e gli si attribuiscono molti altri miracoli. Madre Paz è rimasta a Soriano di Colón, sepolta in una delle cappelle del Santuario de la Dolorosa, vicina dunque al “suo” bambino.




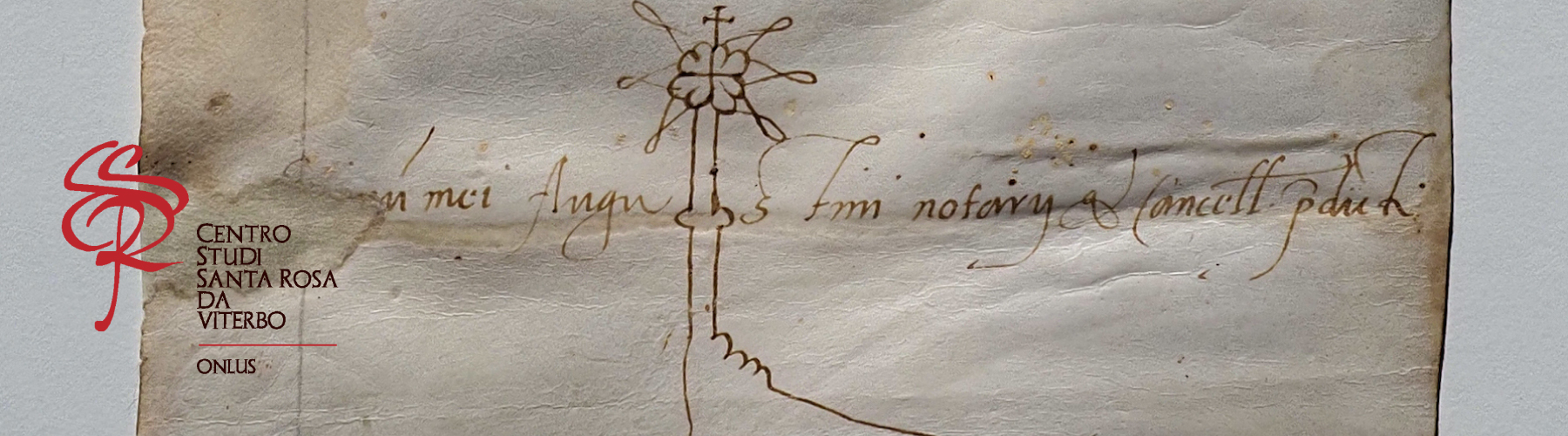







 Preoccupato seriamente per la tenuta dell’intero corpo per il futuro e spinto dalla volontà di “salvare il salvabile”, il medico ebbe facoltà di asportare il cuore della Santa, attraverso un’apertura toracica condotta con estrema diligenza per le conoscenze del tempo. Il piccolissimo organo, che venne in seguito esposto in un primo reliquiario inviato da Benedetto XV e poi in quello attuale, prezioso dono di papa Pio XI, costituisce l’elemento peculiare al centro del dibattito sorto su quella sindrome sfuggente che ha accompagnato la vita di Rosa sin dalla nascita e che oggi la scienza tende ormai ad identificare come “Anomalia di s. Rosa”.
Preoccupato seriamente per la tenuta dell’intero corpo per il futuro e spinto dalla volontà di “salvare il salvabile”, il medico ebbe facoltà di asportare il cuore della Santa, attraverso un’apertura toracica condotta con estrema diligenza per le conoscenze del tempo. Il piccolissimo organo, che venne in seguito esposto in un primo reliquiario inviato da Benedetto XV e poi in quello attuale, prezioso dono di papa Pio XI, costituisce l’elemento peculiare al centro del dibattito sorto su quella sindrome sfuggente che ha accompagnato la vita di Rosa sin dalla nascita e che oggi la scienza tende ormai ad identificare come “Anomalia di s. Rosa”. In una lettera pastorale del 29 ottobre 1921, a conclusione dei lavori, il vescovo Trenta comunicò ai fedeli che da quel momento il bacio della mano sarebbe stato sostituito col bacio di questa nuova preziosa reliquia e a coronamento di questi eventi una solenne processione religiosa col trasporto del corpo e del reliquiario con il cuore della Santa si sarebbe tenuta a Viterbo il 13 novembre 1921 con gran concorso di popolo.
In una lettera pastorale del 29 ottobre 1921, a conclusione dei lavori, il vescovo Trenta comunicò ai fedeli che da quel momento il bacio della mano sarebbe stato sostituito col bacio di questa nuova preziosa reliquia e a coronamento di questi eventi una solenne processione religiosa col trasporto del corpo e del reliquiario con il cuore della Santa si sarebbe tenuta a Viterbo il 13 novembre 1921 con gran concorso di popolo.